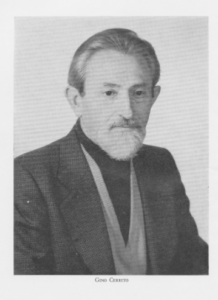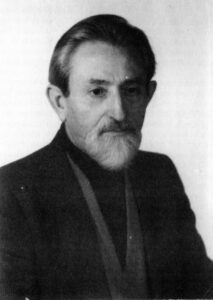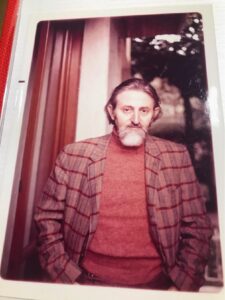Nelle ultime settimane abbiamo assistito agli effetti globali provocati dal conflitto tra la Federazione Russa e l’Ucraina iniziato a fine Febbraio.
Come abbiamo visto qui in Sicilia, questa situazione guerreggiata ha portato ad un aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, in primis alimentari, ma anche dei prezzi energetici, scatenando scene di panico per l’accaparramento di una serie di prodotti.
Il problema inflattivo lo si potrebbe definire “congiunturale”, un problema che va ad aggravare una situazione locale che da diversi decenni presenta problemi cronicizzati: infrastrutture stradali e ferroviarie ridotte a colabrodo o pessime, disoccupazione endemica, tassi di emigrazione alti, spopolamento dei centri urbani più piccoli ed isolati (come nella zona centrale dell’isola) ed impoverimento generale che fa sì che sempre più persone debbano rivolgersi ad enti assistenziali per mettere insieme il pranzo con la cena.
Per rendere ancora più chiara questa situazione, non dimentichiamoci che dopo pochi giorni di lockdown, due anni fa in piena fase emergenziale dovuta alla pandemia, a Palermo ci fu un vero e proprio assalto verso i supermercati.
Senza dimenticare, rimanendo nell’ambito dei problemi di questa regione, che nelle realtà paesane siciliane vi è una mentalità “depoliticizzata” a causa di una combinazione di fattori: il fatalismo tipicamente siciliano, quello che porta ad accettare supinamente il potere costituito; un familismo che porta al “tutti amici tutti” di facciata e ad una lotta infida alle spalle; lo stretto contatto tra sfruttati e sfruttatori nell’ambito di relazioni amicali/familiari; un disprezzo aperto per donne ed individui non etero e non cisgender, e via di questo passo.
In un contesto del genere vi sono una serie di interventi espansivi economici e sociali delle borghesie nazionali ed internazionali: dalla borghesia maltese nella zona del ragusano alla Compagnia delle Opere che erode il potere politico di Sicindustria, fino agli accordi tra le borghesie arabe e cinesi con le amministrazioni comunali delle città metropolitane.
Tutta questa situazione fa gola alle varie fazioni politiche-borghesi regionali in lotta fra loro nell’accaparrarsi sia i favori delle associazioni e gruppi di potere economici nazionali ed internazionali che i fondi provenienti da Bruxelles.
Alle fazioni citate poco importa se alle ultime elezioni regionali del 2017 l’astensione aveva superato abbondantemente il 50%.
Il dato è l’accaparramento continuo e la difesa dei privilegi fino ad ora ottenuti. Indipendentemente dall’attuale situazione sindemica e di stagnazione economica.
Al tempo stesso, il malcontento sociale è stato cavalcato da movimenti come i Forconi e da partiti istituzionali come il Movimento 5 Stelle che hanno promesso una serie di contentini alle fasce più basse della popolazione.
Oggi che il tappo sembra essere saltato, questi gruppi politici non riescono più a frenare l’emorragia sociale di votanti e sfiduciati.
I movimenti che sono emersi in questi anni si sono, via via, assottigliati per una serie di problemi dovuti alle vite personali dei singoli e/o alle velleità manifeste elettorali di tanti altri.
Il deserto politico, sociale e culturale che si è venuto a creare è, quindi, palpabile.
Il movimento anarchico siciliano odierno, si può dire senza timore di smentita, è ridotto al lumicino.
Dal punto di vista della memoria storica, personalità e gruppi vissuti decenni or sono risultano completamente sconosciuti alla generazione di compagni/e più giovani ed in via di formazione; questo perchè le strutture si contano sulle punte delle dita di una mano e i cataloghi per la consultazione o non sono di pubblico dominio o non sono completi.
Da un punto di vista della prassi, l’azione degli sparuti gruppi anarchici siciliani si concentra principalmente nelle principali città e centri urbani, di solito capoluoghi di provincia, mentre i paesi rimangono completamente scoperti.
Ma anche dove sono presenti, le azioni di propaganda e pratica di tali gruppi sono molto ridotte.
Di fronte a tutto questo allora, ci auguriamo che la pubblicazione dell’opuscolo del compagno Gino Cerrito possa essere fonte di stimoli per ravvivare una situazione di depressione culturale, sociale e politica come quella odierna.
Nel suo opuscolo, Cerrito riporta minuziosamente le attività di gruppi ed individualità anarchiche tra il primo ed il secondo dopoguerra: da reduci di esperienze vissute in campi di concentramento come Umberto Consiglio a quelli di lotta armata partigiana durante la guerra come Alfonso Failla, passando alle azioni di Paolo Schicchi durante il periodo fascista.
L’anarchico messinese mostra come questi compagni si organizzavano e giravano in varie zone della Sicilia per portare avanti teorie e pratiche anarchiche, nonostante l’esiguità dei mezzi materiali e delle risorse monetarie allora a disposizione.
Collana Porro, Edizioni RL, Napoli, 1956, 42 p.
Prefazione
La storia del Movimento anarchico italiano, dei fatti e delle idee che l’hanno caratterizzato in circa un secolo di vita e del contributo da esso apportato all’umano progresso, non è stata ancora scritta. Salvo la monografia di Max Nettlau, su « Bakunin e l’Internazionale in Italia dal 1864 al 1872 » (Ginevra, 1928), integrata dal « Mazzini e Bakunine » di Nello Rossellini (Torino, 1927), esistono pochi mal riusciti tentativi cronachistici e memorialistici e talune insufficienti biografie apologetiche, licenziati alle stampe a scopo del tutto propagandistico. Si sente quindi il bisogno di un’opera sistematica sul Movimento anarchico italiano, condotta opportunamente sulle fonti, la quale colmi questa grave lacuna storiografica. Il compito non è dei più semplici: in quanto le difficoltà della ricerca dei materiali necessari sono innumerevoli. Non si tratta solo di utilizzare quanto già pubblicato in opuscoli e libri di propaganda, ma di sfogliare attentamente le collezioni dei quotidiani e dei periodici anarchici e non anarchici (per i periodi di maggior interesse storiografico) e di attingere copiosamente ai dibattiti parlamentari, alla raccolta delle leggi e decreti, ai documenti di archivio, ai processi politici innumerevoli celebrati contro gli anarchici, e di inquadrare gli avvenimenti nella storia generale del paese, per scorgere i limiti del contributo dato dal Movimento anarchico alla causa della libertà.
È stato scritto che « L’anarchismo, che cinquantanni fa aveva una sua vitalità necessariamente correlativa agli altri moti sociali in atto, si trova ora come in un vacuo.
In un vacuo che ha per pareti gelatinose bugie »; che « Gli anarchici, e non solo in Italia, stanno faticosamente cercando strade su cui sia possibile un’azione sociale caratteristica ed efficace » (L. Fabbri , Sotto la minaccia totalitaria, Napoli, 1955, Prefazione degli editori, p. 5). Ebbene, solo mediante una obiettiva esposizione degli avvenimenti vissuti in un secolo di vita del Movimento anarchico italiano, si potranno trarre gli elementi positivi per convalidare e sostanziare la sua attuale ripresa, per risolvere l’immobilismo che attualmente lo travaglia, e per confutare, con le esperienze vissute, l’accusa più volte lanciata contro « l’anarchismo tradizionale ormai superalo ed esautorato dagli avvenimenti ed anchilosati durante gli ultimi decenni nella commemorazione delle proprie date storiche e nella seminagione di proclamazioni fallite » (Un trentennio di attività anarchica, Cesena, 1953, Presentazione degli editori, p. 5).
È con l’augurio che questa esigenza storiografica, profondamente sentita dentro e fuori del nostro Movimento, venga al più presto soddisfatta, che diamo alle stampe questo breve saggio sulla « Rinascita del Movimento anarchico in Sicilia » (cioè sulle esperienze vissute dagli anarchici siciliani dal settembre 1943 al 2 marzo 1947, data del primo Convegno regionale anarchico), già pubblicato in tre puntate dalla rivista «Volontà» (l°luglio-1° settembre 1955, n. 1-3 4, 5, an. IX).
G.C.
1
INTRODUZIONE
Per renderci conto delle difficoltà, che ostacolarono la rinascita del Movimento anarchico in Sicilia, immediatamente dopo l’ 8 settembre 1943, è necessario risalire indietro nel tempo e soffermarci brevemente sulla reale consistenza dei gruppi anarchici siciliani, all’indomani della prima guerra mondiale : mettendo in rilievo la dispersiva azione persecutoria compiuta dai governi Mussolini ed i peculiari motivi che inficiavano lo sviluppo del Movimento anarchico stesso [1].
Bisogna tener presente che, fino all’avvento della dittatura fascista, gli anarchici siciliani mancavano d’un indirizzo teorico chiaro e di un metodo associativo idoneo alle condizioni ambientali dell’isola. Essi aderivano, cioè, alle concezioni antiorganizzative, allora presenti nel Movimento italiano, accentuandone le caratteristiche, per quell’individualismo proprio delle genti di Sicilia. « Io sono se non asocievole, — scriveva uno dei più attivi anarchici di Sicilia, nell’anno 1924 [2] — un animale di difficile socievolezza, ciò non toglie che io abbia trovato un gruppo di persone al quale, oltre da una infinita reciproca tolleranza, sono legato dalla comunione di vedute di molti problemi, nelle linee schematiche. Da questo gruppo di amici sorsero i Figli dell’Etna. Noi siamo individualisti nel senso più radicale, cioè istintivisti. Proclamiamo la libertà dell’individuo di soddisfare tutti i suoi bisogni… Anarchici perchè irriducibili nemici di ogni manifestazione autoritaria, noi rivendichiamo il diritto di dirci tali di fronte al movimento o partito comunista-anarchico, in quanto l’accettazione della verità antiautoritaria non implica l’accettazione di tutta quella roba che alcuni uomini — sia pur rispettabilissimi… — han voluto ricamarci sopra» [3].
La dottrina di costoro — continuava il Di Mauro — di anarchico « non ha che la sovrastruttura ed il coronamento… In forza di quanto abbiamo scritto, insistiamo nella esistenza di due anarchismi, lontanissimi dalle origini — l’uno ha le sue radici nel fatto economico, l’altro nel fatto morale — che s’incontrano sul terreno antiautoritario: quello comunista che va assumendo forme sempre più pratiche, concrete, realizzatrici, come tale compreso nel ciclo storico degli esperimenti sociali e destinato a scomparire tosto che si sarà sperimentato — quello individualista destinato a sopravvivere a tutte le società in quanto di queste sarà sempre l’elemento componente ».
In forza di queste idee, parzialmente comuni agli anarchici siciliani e chiaramente contradittorie, si rifuggiva dal partecipare ad una metodica attività di gruppi federati, come si respingeva una costante partecipazione al Movimento operaio, accontentandosi — salvo qualche eccezione — di impegnarvisi a fondo, quando le campagne per le rivendicazioni salariali o per l’occupazione della terra si trasformavano in veri e propri conflitti con le forze di polizia.
I motivi di queste deficienze caratteristiche — riscontrate nella pubblicistica anarchica siciliana del tempo — scaturivano dalla formazione mentale essenzialmente romantica e, pertanto, dati i tempi e le esigenze, retorica dei numerosi intellettuali siciliani, che aderivano al Movimento anarchico, distogliendolo spesso da quelle reali e conseguenti idee-azioni, che riaffioravano solo periodicamente e in virtù della pressione interna dell’elemento operaio ed esterna delle masse popolari.
La figura di maggiore rilievo che allora dominava — possiamo dire — con la sua prestigiosa ed energica personalità gli anarchici di Palermo e che influenzava notevolmente tutto il Movimento dell’isola, era Paolo Schicchi di Collesano, la cui vita si identifica ed è tutt’uno con la vita dell’anarchismo a Palermo.[4] Istintivista e nemico di ogni organizzazione di gruppo e di ogni metodica attività continuativa, Paolo Schicchi viveva nella lotta e per la lotta, rischiando molto spesso la vita e la libertà e pagando sempre di persona. Per temperamento esuberante, riteneva un’ imperdonabile vigliaccheria sottrarsi al pericolo, sotto qualunque forma esso si presentasse.
Era ed è sempre rimasto un vecchio anarchico dell’ «Epoca eroica » e, da buon siciliano, nutriva un profondo senso dell’onore, inteso alla maniera siciliana, che lo trascinava ad emettere sentenze troppo arrischiate e soggettive; e non solo nei riguardi dei nemici dell’anarchismo, ma altresì di quegli anarchici che avessero assunto atteggiamenti più o meno contrari al suo modo di concepire l’anarchismo. Diventava a volte, in altre parole, il sacerdote che approva e condanna; e tuttavia, trasudava da lui quella manifesta buona fede e quella profonda e rude lealtà, che lo rendevano caro a chiunque lo conoscesse.
Nel primo dopoguerra, Paolo Schicchi prestava un’attività propagandistica individuale intensissima: oltre i contatti costanti con i compagni di ogni centro dell’isola, ai quali forniva giornali, opuscoli e consigli — particolarmente richiesti in quei difficili momenti —, e le ininterrotte corrispondenze con parecchie individualità della penisola e dell’estero; presenziava, insieme con altri anarchici di Palermo,[5] alle innumerevoli agitazioni operaie e contadine che avevano luogo nel suo circondario e trovava il tempo, altresì, per pubblicare e diffondere vari numeri-unici, prima, ed un periodico quindicinale, poi, il quale veniva soppresso definitivamente nell’ottobre 1923.
Dalla seconda metà del 1920 ai primi del 1921, venivano pubblicati a Palermo o a Collesano, per la redazione di Paolo Schicchi, i numeri unici La Zolfara, il Piccone e La Zappa, i cui titoli danno sufficienti ragguagli sulle lotte che lo Schicchi ed i suoi collaboratori sostenevano; [6] il 6 giugno 1921, iniziava le pubblicazioni quindicinali II Vespro Anarchico, compilato da Paolo Schicchi e Nino Napolitano, con la collaborazione di Ugo Fedeli, e diffuso in Sicilia da numerosi anarchici e socialisti, entusiasti dello stile barricatiero del giornale e legati sentimentalmente al « Leone di Collesano », come lo Schicchi veniva designato dagli amici. [7]
L’occupazione della terra da parte dei contadini, il problema delle zolfare siciliane, gli abusi delle clientele locali, i vizi « costitutivi » della monarchia e della casa Savoia, l’azione provocatoria delle « squadre fasciste » e l’incitamento all’azione diretta popolare e rivoluzionaria erano i principali motivi agitati dal periodico; e, pertanto, le persecuzioni della P. S. contro i suoi redattori e diffusori ed i sequestri ordinati dalla Magistratura furono tali, da dare al Vespro Anarchico quel carattere di semi-clandestinità, che molto spesso provocava richieste maggiori da parte degli operai.
Questa attività individuale dello Schicchi, comunque viziata e contraddittoria — specialmente perchè tendente, intorno al 1921-1923, al fronte di tutte le forze rivoluzionarie per stroncare il nascente fascismo —, arricchiva di nuove reclute, più o meno mature politicamente e socialmente, il Movimento anarchico che già di per sè annoverava estese simpatie in tutto il Movimento socialista diciannovista isolano, alimentato in parte rilevante dalla pubblicistica libertaria e agitante, per ciò appunto, i motivi dell’anarchismo.
Proprio per le deficienze « istintiviste » degli anarchici, caratterizzate da una miriade di azioni rivoluzionarie slegate, e perciò più facilmente represse dalle forze di polizia, era comunissimo il caso del nominale ma non effettivo gruppo locale, costituito intorno a qualche forte personalità, la quale praticamente impediva qualsiasi metodico impegno associativo-funzionale fra i gruppi e nel gruppo, conformandosi alla posizione di Paolo Schicchi, che per molti versi rappresentava l’ Anarchico. Era questa, in fondo, la realtà del Movimento anarchico siciliano, ovunque esistessero gruppi nominali: a Palermo, come a Bagheria, a Casteldaccia, a Collesano, a Trapani, a Castelvetrano, a Mazara, a Salemi, ad Alessandria della Rocca, a Burgio, a Lucca Sicula, a Naro, a Ribera, a Sciacca, a Caltanisetta, a Terranova, a Vittoria, a Lentini, a Francofonte, a Catania, a Grammichele, a Paterno, a Vizzini, a Messina, a Librizzi, a San Piero Patti ed altrove.
Dove, invece, — come a Girgenti, a Marsala, a Modica e, particolarmente, a Siracusa — i gruppi annoveravano un numero notevole di operai politicamente e socialmente maturi e, quindi, aderenti alle locali esigenze e possibilità e necessariamente impegnati nella partecipazione al Movimento operaio, ivi le affermazioni dottrinali proposte da un Di Mauro e superficialmente accettate dagli altri, venivano accantonate e superate da una coordinata attività propagandistica e rivoluzionaria, che trovava nelle masse lavoratrici il proprio naturale terreno di diffusione.
A Siracusa, l’anarchismo cominciò a diffondersi immediatamente dopo la prima guerra mondiale, per la propaganda espletata da alcuni socialisti, fra i quali circolavano le opere della piccola biblioteca del vecchio anarchico Emanuele Maieli, da poco rimpatriato dal Brasile, ed ai quali pervenivano giornali ed opuscoli anarchici, spediti loro dal siracusano Francesco Cappuccio, emigrato a Firenze. Il bracciante agricolo Maieli ed il pittore-decoratore Cappuccio contavano numerosi amici fra gli operai ed i contadini iscritti alla locale sezione del Partito socialista, e, nonostante fosse opinione comune fra i socialisti — i quali coltivavano genericamente e propagandavano i principi anarchici — che le condizioni dell’isola imponessero a tutti i lavoratori di rimanere nelle file del Partito, per ovvi motivi tattico-ambientali, fu proprio da costoro che vennero fuori i primi anarchici siracusani. Pertanto, il Movimento anarchico nacque e prosperò negli anni più critici del primo dopoguerra, cioè all’epoca dei grandi movimenti contadini per l’occupazione delle terre e della prima formazione del Partito fascista. Ad esso aderirono, oltre che vari operai salariati e braccianti agricoli, un gruppo di intellettuali e di studenti. Fra essi si ricordano il rag. Umberto Consiglio,[8] la prof. Eva Ballariano, gli studenti Totò Di Mauro ed Elio Vittorini, gli operai Marcello Cicero, Giuseppe Burgio, Agostino Fugali, Corrado Alessi, Luigi Catania e Giuseppe Sirugo e il giovanissimo Alfonso Failla.
Ben presto, vennero costituiti i gruppi anarchici « Bakunin » ed « I Figli dell’Etna », i quali s’impegnarono in una attività propagandistica intensa e coordinata, svolta in città e nelle campagne adiacenti, con continue conversazioni nelle sezioni socialiste e nelle Camere del lavoro e con distribuzione di migliaia di copie di giornali ed opuscoli, dei quali si ricorda particolarmente il « Fra contadini » di Errico Malatesta, edito nel 1922 da Giovanni Repetto a Rivarolo Ligure, per essere diffuso fra i contadini del meridione d’Italia. In merito alle numerose simpatie di cui godevano i gruppi di Siracusa, è indicativa la costituzione di una Biblioteca anarchica, nei medesimi locali di quella Camera Confederale del Lavoro.
Con l’avvento al potere di Benito Mussolini, a Siracusa come altrove, gli anarchici siciliani furono compatti nella lotta armata contro le squadre fasciste, a fianco dei lavoratori e dei socialisti, ed in prima linea nella difesa delle Camere del Lavoro e delle sedi dei giornali e dei partiti politici antifascisti. Essi si battevano sia mediante l’azione diretta, nel senso più largo del termine, alla quale chiamavano tutto il popolo; sia mediante la diffusione di volantini, di periodici e di numeri-unici, molti dei quali stampati « alla macchia » nello stesso periodo in cui veniva pubblicato a Palermo II Vespro Anarchico, e dopo la sua stessa soppressione, l’arresto e la fuga dall’isola di Paolo Schicchi, avvenute rispettivamente nell’ottobre 1923 e alla metà del 1924. [9]
Vennero pubblicati, fra l’altro, diversi numeri del periodico II Piccone, edito dal gruppo di Catania e compilato da Giovanni Consalvo, nella prima metà del 1922 ;[10] il 1° maggio dello stesso anno i gruppi di Siracusa stamparono a Noto il numero-unico Bandiera Nera, diffuso nonostante il sequestro ordinato dalla Magistratura; e dopo qualche mese, con una piccola macchina tipografica gelosamente custodita a Lentini, il picconiere Francesco Martinez iniziò la pubblicazione periodica de II Seme Anarchico, che uscì con una certa regolarità per circa due anni.[11]
Nel medesimo periodo, il gruppo anarchico « Rupe Athenea » di Girgenti [12] diede alle stampe un numero unico, di cui c’è stato impossibile conoscere il titolo; nel 1924, Gaetano Di Bartolo Milana di Terranova di Sicilia,[13] pubblicò ivi La Fiaccola Anarchica, numero-unico poligrafato; mentre gli anarchici di Siracusa davano alle stampe due volumetti di versi libertari di intonazione individualista di Renzo Novatore,[14] i quali contribuivano in quei critici momenti alla propaganda per l’azione diretta rivoluzionaria. Perduta poi ogni speranza di pubblicazione della rivista II Maglio, progettata da « I Figli dell’Etna », nel 1924 gli anarchici di Siracusa compilavano e diffondevano il numero-unico ciclostilato L’Anormale, « giornaletto dattiloscritto dedicato ai normali ».[15]
Dal 1925, all’incrudire delle persecuzioni fasciste, rispose da una parte l’assottigliarsi dei gruppi anarchici in ogni località dell’ isola;[16] dall’altra un inasprimento della lotta degli anarchici rimasti, contro le « squadre punitive » e contro la P. S. Vari episodi di sangue caratterizzarono quegli anni, che videro rapidamente stroncata ogni istanza di libertà e di miglioramento sociale. Vanno particolarmente ricordati i conflitti contro la reazione governativa, a cui parteciparono variamente, finoltre il 1926, gli anarchici di Palermo, e per essi Paolo Schicchi, Marcello Natoli e Salvatore Tavormina; quelli di Alcamo e di Trapani, dei quali si citano il giornalista Gaspare Cannone e il rag. Filippo Gramignano; quelli di Castelvetrano e di Marsala, fra cui Rosario Dieci due, Ciccio Sammartano, Masi Gandolfo e Cosimo Alagna; quelli di Naro, che intorno al 1923 perdettero, in seguito ad un conflitto con i fascisti, l’avv. Gaetano Pontillo; quelli di Caltanisetta, dei quali si ricordano il ferroviere Raffaele Frugis e il calzolaio Michele Mongione; quelli di Terranova, con alla testa Gaetano Di Bartolo Milana; quelli di Catania, e fra essi Giovanni Consalvo e l’universitario Pietro Basile; quelli di Vizzini, con l’agricoltore Francesco Bruno Curiale; quelli della provincia di Messina, e fra essi Nino Puglisi, morto in seguito alle persecuzioni, Leone Mannozzi, Natale Fusco, Leo Giancola, emigrato in seguito ad incidenti che ebbero luogo durante un’agitazione di contadini, e l’allora giovane simpatizzante Vincenzo Mazzone; quelli di Modica, con i contadini Vacirca e Polara, i quali, il 29 maggio 1921, alla testa dei lavoratori furono falciati dal piombo fascista; quelli di Lentini, e particolarmente il picconiere Francesco Martinez, lungamente perseguitato; quelli di Siracusa, infine, i quali, nel corso del 1925, costituito un gruppo di azione rivoluzionaria — comprendente Umberto Consiglio, Marcello Cicero, Giuseppe Burgio, Alfonso Failla, Giuseppe Sirugo e numerosi simpatizzanti —, riuscirono a trascinare centinaia di lavoratori, stanchi degli abusi fascisti, contro le « spavalde centurie », che periodicamente giungevano a Siracusa dalla Romagna per imbarcarsi per Tripoli, e indussero il governo, in seguito ai numerosi scacchi inflitti alla Milizia fascista, a fare imbarcare da Napoli le « Camice nere ».
Con l’istituzione del « Tribunale Speciale per la difesa dello Stato » e delle « Commissioni provinciali per l’assegnazione del Confino di Polizia »[17] per gli anarchici la vita divenne estremamente difficile. Coloro che per varie ragioni non avevano potuto lasciare l’Italia,[18] venivano arrestati e confinati; mentre i rimasti erano guardati a vista, continuamente fermati, diffidati, ammoniti.[19] Nonostante ciò, la propaganda in Sicilia venne ancora svolta per vari anni dai pochissimi, isolati o riuniti in gruppetti clandestini, in regolare corrispondenza di propositi con quelli di altri centri della penisola e con gli emigrati a Tunisi, a Parigi, a Ginevra e negli Stati Uniti d’America.
Dall’estero, dove rinascevano le iniziative anarchiche stroncate ad una ad una dalla violenza fascista in patria, e dove si avvertiva la primarietà della liquidazione del fascismo delle « squadre punitive » e del « confino di polizia », si mantenevano vive le intese con i rimasti alla mercè dei nemici, si inviava loro materiale di propaganda antifascista e rivoluzionario,[20] si animavano ed incitavano i compagni di tenersi pronti per il momento della riscossa.
Intorno al 1930, date le larghe amicizie e le estese simpatie di cui godevano in patria i componenti siciliani della colonia anarchica di Tunisi. Paolo Schicchi si prefisse di suscitare con l’esempio della propria audacia un moto di ribellione, che avesse inizio nelle provincie di Palermo e di Trapani. Tramite marinai francesi o italiani, che facevano la spola fra i porti della Sicilia e quello di Tunisi, lo Schicchi intensificò la corrispondenza epistolare con gli anarchici rimasti nelle due provincie, e riallacciò le relazioni con alcuni gruppi di simpatizzanti provatamente sicuri. Alla metà del 1930, le sollevazioni popolari contro le tassazioni e la disoccupazione, che ebbero luogo in vari paesi della Sicilia centro-occidentale, lo convinsero che mai sarebbe giunto momento più opportuno, per realizzare lo sperato moto rivoluzionario [21]. E, senz’altri indugi, avvertiti i gruppi clandestini dell’isola, s’imbarcò per Palermo insieme con i trapanesi Salvatore Renda e Filippo Gramignano. Traditi dallo stesso capitano della nave che li trasportava, i tre anarchici vennero catturati nel porto di Palermo e condannati rispettivamente a dieci, otto e sei anni di reclusione. [22]
Contemporaneamente vennero arrestati molti componenti dei gruppi rivoluzionari promossi dallo Schicchi, fra i quali gli anarchici Calogero Aronica Pontillo di Naro e Nino Guarisco di Burgio, allora a Palermo, e l’insegnante antifascista Enrico Soresi di Partinico.[23]
Dopo il fallimento di questo progetto di rivolta collettiva e organizzata, e dopo la fuga a Tunisi dell’ultimo attivo e funzionale nucleo anarchico siracusano — composto da Giuseppe Burgio, Marcello Cicero, Luciano Miceli, Giuseppe Politi e Salvatore Vaccaro[24] — , la situazione generale interna veniva caratterizzata, fino al 1943, dall’isolamento sempre più accentuato dei perseguitati — indicati col termine generico di antifascisti, sovversivi o bolscevichi — e dall’affollamento dell’isola di Ponza, di Ventotene, di Tremiti, dove si ripensavano gli errori del diciannovismo e si formavano politicamente e socialmente i più giovani. Mentre l’attenzione dei fuorusciti era polarizzata per più anni dalla Spagna repubblicana e rivoluzionaria, per la quale lottarono gli anarchici siciliani Paolo Caponetto di Francofonte, Vincenzo Mazzone di Messina, Giovanni Fontana di Pantelleria, Celestino Carta di Enna, Giuseppe Burgio, Giuseppe Politi, Giuseppe Livolsi e Umberto Consiglio di Siracusa.[25]
Continua nella Seconda Parte
Note
[1] Per la compilazione della presente esposizione critica mi sono servito delle fonti a cui farò riferimenti nelle note e nelle memorie dei seguenti anarchici che ho avuto modo di intervistare: Giuseppe Alticozzi di Modica, Celestino Carta di Enna, Marcello Cicero di Siracusa, Gerlando Diana di Caltanissetta, Rosario Diecidue di Castelvetrano, Alfonso Failla di Siracusa, Filippo Gramignano di Trapani, Franco Leggio di Ragusa, Vincenzo Mazzone di Messina, Salvatore Siracusa di Agrigento, Pio Turroni di Cesena. Ringrazio particolarmente Rosario Diecidue ed Alfonso Failla per la documentazione fornitami. Per quanto riguarda la rinascita del Movimento anarchico dal Congresso di Carrara al Convegno regionale di Palermo mi sono giovato anche di personali memorie e di documenti in mio possesso.
[2] T. DI MAURO , Appendice, in R. NOVATORE , Al di sopra dell’arco. Arte libera di uno spirito libero, ed «I Figli dell’Etna» di Siracusa, Roma, 1924, pp. 82-3.
[3] Si riferisce particolarmente a Errico Malatesta ed al patto federativo approvato nel Convegno anarchico di Bologna del 1920.
[4] Paolo Schicchi morì a Palermo il 12 dicembre 1950. Per una breve biografia dello stesso rimandiamo a Seme Anarchico, Torino, 1 dicembre 1952 (A. I, n. 12), e agli altri giornali anarchici dell’epoca della morte.
[5] Particolarmente con Marcello Natoli, Nino Napolitano, Salvatore Tavormina.
[6] Cfr. U. FEDELI , Giornali, riviste, numeri unici anarchici stampati in italiano dal 1914 al periodo clandestino, in Movimento Operaio, giugno-luglio 1950 (A. II, n. 9-10).
[7] Sul Vespro Anarchico, cfr. U. FEDELI, cit.
[8] Umberto Consiglio è uno degli attuali redattori di Umanità Nova, settimanale anarchico edito a Roma.
[9] Cfr. Un trentennio di attività anarchica (1914-1945), ed. L’Antistato, Torino, 1953, p. 80; SOLITO VILLA (Calogero Aronica Pontillo), Le peripezie d’un compagno sotto il fascismo, in L’Adunata dei Refrattari, New York, 6 gennaio 1945 (a. XXIV, n. 1).
[10]Cfr. U. FEDELI , cit.
[11] II Fedeli, nell’art. cit., riferisce erroneamente che il periodico usci a Catania e solo per pochi mesi. Il redattore del giornale, F. Martinez, lungamente perseguitato, morì durante il ventennio; gli aderenti al gruppo da lui animato si iscrissero nel 1943 al P. C. I.
[12] II gruppo di Girgenti (l’attuale Agrigento) era composto da Gaetano Caglio, Leopoldo Castellino, Vincenzo Ferlisi, Ignazio Mattiolo, Vincenzo Piazza ed altri.
[13] Gaetano Di Bartolo Milana di Terranova (l’attuale Gela), alla fine del 1924 propose la fondazione di un partito anarchico e incontrò l’opposizione di Errico Malatesta, che pubblicò degli articoli in Pensiero e Volontà del medesimo periodo. Il Di Bartolo inviò corrispondenze all’Adunata dei Refrattari, sotto lo pseudonimo di Nunzio Tempesta, fino al 1932; scoperto, venne inviato a Ponza per 5 anni.
[14] II secondo volumetto di versi del Novatore porta il titolo Verso il nulla creatore.
[15] Per II Maglio, cfr. T. DI MAURO , Appendice cit., pp. 86-7; per L’Anormale cfr. U. FEDELI , art. cit.
[16] Molti anarchici emigrarono (Salvatore Battaglia di Agrigento, Giuseppe Gloriando di Grammichele, Eva Ballariano di Siracusa, Michele Abbate di Casteldaccia, poi abusivamente catturato a Tunisi dai fascisti e internato a Ponza dove morì, ecc.), altri si allontanarono dal Movimento per vari motivi (I. Buttitta di Bagheria, T. Di Mauro ed Elio Vittorini di Siracusa ecc.).
[17] Cfr. la Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 1926.
[18] Nel 1926 e negli anni seguenti altri anarchici lasciarono l’Italia: Umberto Consiglio di Siracusa, Giuseppe Fiducia di Siracusa, Filippo Gramignano e Salvatore Renda di Trapani, Nino Napolitano e Marcello Natoli di Palermo, Vincenzo Mazzone di Messina ecc.
Nel 1926, Nino Puglisi di Librizzi, scriveva a Leo Giancola a Miami: «Dopo tanti anni trascorsi dacché tu ti allontanasti dalla terra su cui si sono abbattute migliaia di bufere, colgo l’occasione per scriverti, per dirti che ancora sono al mio posto di battaglia. Nessuno valse a farmi piegare la fronte. Errante di paese in paese, dopo che terminai quella che la società attuale chiama condanna restrittiva: in un momento di mesto raccoglimento, rifaccio tutto il mio passato; e ripensando attraverso un sogno vago giorni di mia vita politica trascorsi insieme a le ed altri, il cuore mi sanguina, e mi domando: dove siete fuggiti? Resto ramingo e solo in questa terra, culla millenaria di imposture, che il sangue di tanti martiri non è valso a cancellare, qui, dove gli uomini più abietti, in forma di una immensa piovra, succhiano il sangue di un popolo… » (cfr. L. GIANCOLA, Gli sconosciuti, in Adunata dei Refrattari, 3 marzo 1945 (a. XXIV,n. 9). Nino Puglisi morì durante il ventennio nel Manicomio criminale di Barcellona, dov’era stato rinchiuso dal regime.
[19] Ricordiamo i confinati Nino Catalano e Vincenzo Marzo di Mazara, Michele Mongione di Caltanissetta, Alfonso Failla di Siracusa; ed i variamente perseguitati Gaetano Caglio di Agrigento, Raffaele Frugis di Foggia, residente a Caltanissetta, Gaetano Miano di Messina, Calogero Aronica Pontillo di Naro, Nino Guarisco di Burgio, Giovanni Bufalo di Lucca Sicula.
[20] II materiale veniva inviato sia ad amici poco conosciuti dalla polizia, sia indiscriminatamente ad indirizzi tratti dalle guide telefoniche, per generare confusione nelle autorità.
[21] Si verificarono sollevazioni a Borgetto, Castiglione, Linguaglossa, Pachino, Partinico, Randazzo e in vari altri paesi, sempre per i tradizionali motivi.
[22] Cfr. Un trentennio di attività anarchica, op. cit., pp. 96 sgg. Dei tre condannati il Renda chiese, poco dopo, la grazia e fu posto in libertà.
[23] Cfr. SOLITO VILLA , art. cit.
[24] II gruppetto fuggì a Tunisi in motopeschereccio.
[25] Giuseppe Livolsi cadde il 12 novembre 1936 nell’attacco di Almudevar (Aragon), (cfr. Un trentennio…. op. cit., p. 186).